Marco Marchetti recensisce l’inedito horror inglese di David Keating, che segna un ritorno della storica label all’altezza della sua fama di fucina di brividi indipendenti, un passo più in là del mainstream.
Sembra che i bambini scalcino per essere al centro del recente cinema horror britannico. Il progenitore e capostipite, da cui il nefando lignaggio discenderebbe, parrebbe un in Italia misconosciuto (ma notevole) The Children (2008) a firma di un altrettanto (semi)misconosciuto Tom Shankland, sulfurea pellicola, la sua, che col film in questione condivide l’attrice principale, tale (e pure lei misconosciuta) Eva Birthistle. La ragazza è bella, molto bella, va da sé, ed è curioso notare come, casualità o sinistra predestinazione, i suoi personaggi siano quelli della mater dolorosa che, nell’un lavoro come nell’altro, sguazza tra marmocchi con più di un diavolo per capello. Sono sempre i figliocci a dare problemi, perché nel film di Shankland, calco sovversivo dell’ancor più sovvertitore Ma come si può uccidere un bambino di Serrador (1976), la progenie “normale” si piglia una mezza influenza in seguito alla quale fa mattanza di chiunque abbia raggiunto l’adolescenza.
[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles6_wake-wood-2.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles6_wake-wood-2.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles6/wake-wood-2.jpg” target=”” effect=”tilt”]
Le scene torcibudella non mancano, anzi, un ignaro papà, reo di aver spinto la figlia ad abortire tempo prima, si ritrova squartato e rimpinzato con un bambolotto nel ventre. Il quale automa, un piccolo bijou hoffmaniano in vena di scherzetti, emette degli strani vagiti che spingeranno qualcheduno ad avvicinarsi circospetto e a fare la nefanda scoperta.
Cosa c’entra con Wake Wood? C’entra eccome, perché oltre alla protagonista, il film di David Keating conserva alcune delle tematiche principali del cugino Shankland, tematiche che, pur declinandosi e sviluppandosi in modo totalmente autonomo, si rifanno all’opera in questione non come una filiazione, piuttosto come un’aggiunta. È forse lo stesso fenomeno alla base del filone iberico-demoniaco che, da La spina del diavolo (2001) a The Orphanage (2007), rende insonni le nostre notti con bambini posseduti e case infestate.
[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles6_wake wood 3.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles6_wake wood 3.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles6/wake wood 3.jpg” target=”” effect=”tilt”]
Wake Wood si muove in questo stesso estremismo concettuale, tanto che ne parrebbe, a tratti, non dico un consanguineo, ma senz’altro un degno epigono. Qui la bella Louise (la Birthistle) ci fa una figura migliore, è un po’ meno rintronata della sua precedente gemella e si accorge sin da subito, o perlomeno lo intuisce, che alla figlia, la piccola, sdentata e alienata Alice (Ella Connolly), mancherebbe giusto un qualche venerdì. D’altronde lei fa la farmacista, il marito Patrick (Aidan Gillen, volto risucchiato dal piccolo schermo) il veterinario e non si capisce come la bimbetta, nella scena iniziale, possa essere così scema da aprire un cancello per dar da mangiare a un cagnaccio rognoso e parecchio arrabbiato. Ça va sans dire, la poveretta fa la fine del prosciutto e tanti saluti.
[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles6_wake wood 4.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles6_wake wood 4.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles6/wake wood 4.jpg” target=”” effect=”tilt”]
Poi i genitori disperati cambiano aria e vanno a vivere in campagna (a Wake Wood, appunto, evocativo sin dal nome) dove una specie di setta di persone (all’apparenza) bonarie e tranquille si dedica alla negromanzia, resuscitando i morti. L’occasione è ghiotta, e così i mesti coniugi si impegolano con rituali proibiti, cerimoniali sacri e usanze locali che, pur travestite da innocuo folclore, nascondono un penetrante odore di zolfo. Le regole sono restrittive, ma se si sottoscrive il mefitico patto con le Tenebre, bisogna rispettarne tutte le postille e le clausole. Altrimenti esse si ripigliano tutto con gli interessi. L’accordo, tacito e ancestrale come gli antichi e sussurranti boschi, è molto semplice: la piccola Alice potrà tornare tale e quale coi genitori, ma solo per tre giorni, non un minuto di più. All’imbrunire del terzo giorno, dovrà essere riportata nel bosco perché possa ridiscendere nel Tartaro. I due sono ovviamente duri di comprendonio, e non colgono se non all’ultimo istante i casini in cui si stanno cacciando, fatto sta che si riprendono la figlia ma non la vogliono riconsegnare a quei burberi del villaggio. Così il Male ottenebra l’innocente cuore di Alice che, allo scadere del tempo, dà di matto e se ne va in giro a sgozzare, appendere, sbudellare la gente. Ah, sì, scuoia pure un cane, attaccato poi alla porta di casa come uno scacciaspiriti.
La quota Hammer si vede eccome, soprattutto nella scena notturna di evocazione dei morti, con queste facce da paesani superstiziosi, il borgo medievale, la ritualistica draculesca che richiama, in una deliziosa parentesi vintage, il fascino pestilenziale dell’epoca d’oro della casa britannica. Tutto questo è molto interessante, anche e soprattutto perché l’altro film, interamente prodotto dalla Hammer, cioè The Resident (2011) di, come dire, “hammeriano”, non aveva pressoché nulla, tranne un Cristopher Lee riciclato in un’eco-balla e gettato nel mucchio per far quadrare i conti. Poi c’era la cavallona della Hilary Swank, tutta spigolosa, androgina e fottutamente sexy, ma che in fin dei conti stonava alquanto con l’insieme. Insomma, era un film sfiatato, diciamocelo chiaramente, più simile al remake hooperiano di Toolbox Murder (2004) che ad altro. Persino la scena in cui la bella Swank si spalmava di crema era un anestetico per le erezioni, così demodé, così brutto, appunto.
[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles6_wake wood 5.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles6_wake wood 5.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles6/wake wood 5.jpg” target=”” effect=”tilt”]
Ma torniamo a Wake Wood. Ci sono tanti e validi motivi per vederlo. David Keating, un regista o forse un mestierante (da noi s’è visto un L’ultimo dei grandi re, 1996) ha comunque fatto il colpaccio dirigendo la sceneggiatura di Brendan McCharty, un tipo che al solito fa il produttore (eh sì, è lui quello di Isolation o Breakfast on Pluto) ma che qui si diletta nella scrittura creativa con meriti di gran lunga superiori a quelli del filmaccio di Neil Jordan.
Si parte d’altronde subito a caldo, rara virtù in molto cinema, con un’accoppiata di scene che cita e riscatta al tempo stesso i maestri del body dismemberment, primo fra tutti l’Alberto Cavallone di Spell, l’uomo, la donna, la bestia (1977). Già, la bestia, meglio le bestie, che aprono il carosello degli orrori con una mucca squadernata con un cesareo e tanto di vitello insanguinato; e poi il pastore tedesco che azzanna la giovane vittima alla gola, tutto senza censura in un’apoteosi di puro delirio splatter. Persino il rito della rinascita ha qualcosa di profondamente cavalloniano, con questo cadavere ricoperto di fango e trasformato col fuoco in un contenitore d’argilla antropomorfo dal quale, fratturato a mazzate, fuoriesce la piccola Alice, immersa proprio in un utero di frattaglie e budella.
E infine, a completamento del trittico (o del quartetto, se si volesse considerare il randagio scorticato di cui sopra) ecco un gigantesco toro che spappola contro una cancellata lo sprovveduto allevatore. La macchina da presa indaga i recessi della carne, penetra l’anatomia distruggendone i segreti, frulla con indistinta pignoleria le suggestioni della moderna école française di Martyrs o À l’interieur con la lezione di un Robin Hardy (quello di The Wicker Man, s’intende).
[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles6_wake wood 6.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles6_wake wood 6.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles6/wake wood 6.jpg” target=”” effect=”tilt”]
Wake Wood deve molto, però, anche a Cimitero vivente (1989). È innegabile appuntarne una qual certa analogia che, in una simmetria barocca e alquanto fantasticata, fa di Alice il degno pendant dell’indifeso Gage, il pargolo kingiano che nel capolavoro di Mary Lambert si trasformava in un bastardello assassino munito di bisturi.
Sempre il bisturi arma la mano di un altro feto sopravvissuto del cinema, il perfido Milo dell’omonimo film di Pascal Franchot (1998), qui citato dalla mantella gialla indossata dalla protagonista. Ella a dire il vero non usa proprio gli strumenti della chirurgia per mietere le sue vittime, quanto coltellacci o altri utensili domestici recuperati qua e là, ma qualunque sia l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Prima ammazza un vegliardo a colpi di rastrello poi, con un affondo secco in stile Venerdì 13, buca la carotide a un’elegante signora, la cui unica colpa era stata consultare un magico abbaco per informare la famiglia della malvagità della bambina.
Pian piano, omicidio per omicidio, delitto per delitto, ecco che strisciamo verso l’inquietante finale, un serraglio boschivo fatto di pagani abitanti che, libri, preghiere e formule alla mano, tentano di riportare la giovane Alice nel paese delle meraviglie, di farle fare una bella discesa nel mare delle tenebre e in ciò che in esso v’è d’esplorabile. Tentano, appunto. Non si svela niente del twist, ma Wake Wood, con le sue pale eoliche che ruotano infinitamente in una brezza preternaturale e funerea, le sue foreste intricate, gli arcaici alberi bisbiglianti, ha in serbo qualcosa di così perfido e aberrante da far tremare perfino lo spettatore più avveduto.
Vedere per credere.
Marco Marchetti

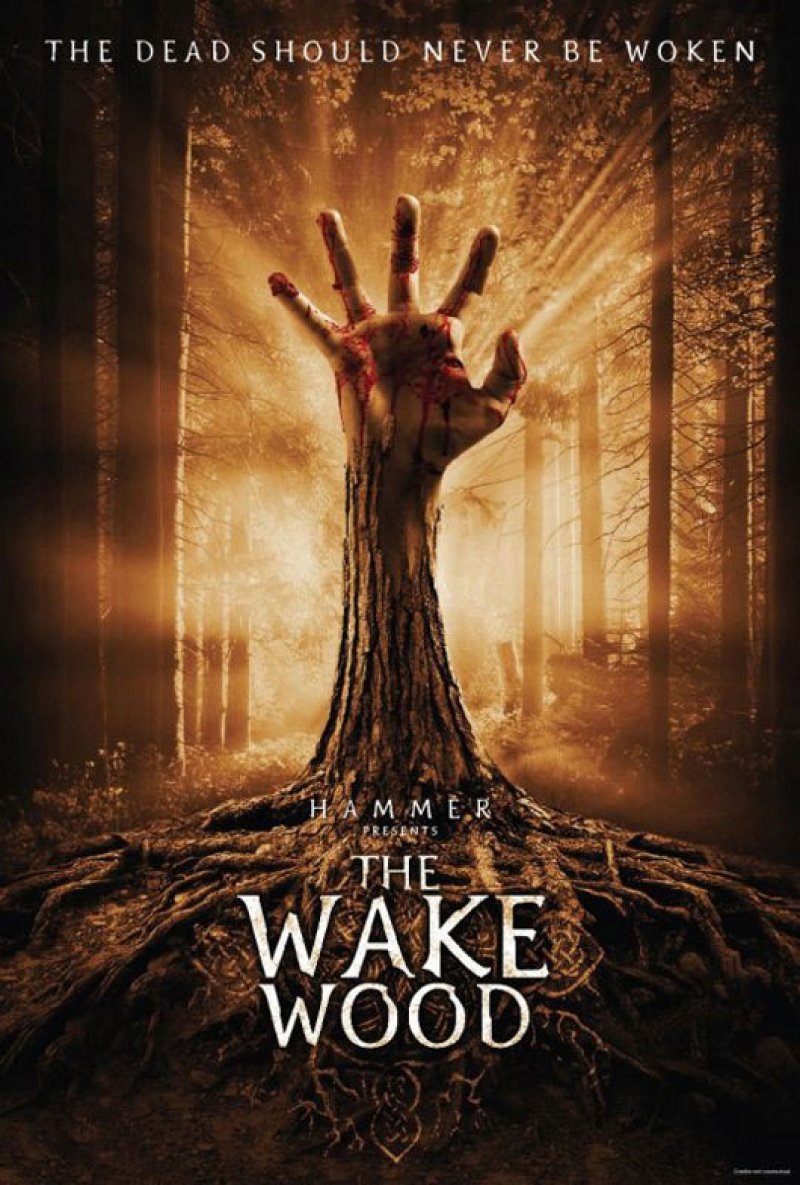
Lascia un commento